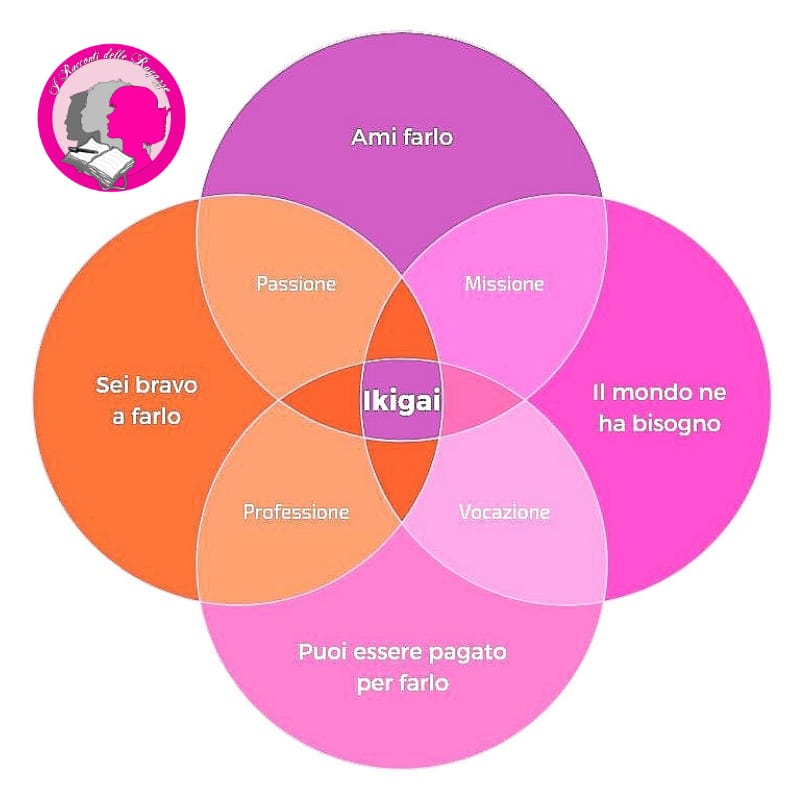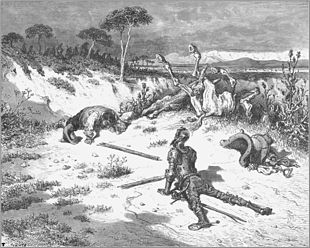È la prima volta che non accompagno al nome di Adolf Hitler una qualifica che lo identifichi per quello che di fatto è stato: un mostro.
È superfluo sottolineare quanto l’animo spietato di questo uomo abbia sollevato lo sdegno di intere generazioni, dopo la tragedia dell’Olocausto durante la seconda guerra mondiale e parlarne non significa, per me, trovare scusanti o giustificare la condotta criminale di un invasato. Se oggi faccio quel nome è perché ho letto un libro che parla di lui tentando un approccio nuovo, che mi ha incuriosita. Si tratta di un romanzo che mira a infrangere un tabù, senza pretendere di “assolvere” chi è già stato condannato dalla storia.
Sto parlando di “H – Come Hitler vedeva i suoi tedeschi” di Johann Lerchenwald, pubblicato dalla casa editrice Jouvence, che racconta in modo accurato l’iter biografico del Führer, dall’infanzia fino all’ascesa al potere, senza dare dei giudizi di tipo morale, ma mostrando un percorso di scelte, scivolate lentamente, negli anni, verso il baratro dell’odio e della violenza.
Il tentativo dell’autore di smontare l’impenetrabile aura demoniaca di Hitler passa attraverso un punto di vista inedito, quello del protagonista stesso, che, tuttavia, parla in terza persona, per creare un certo distacco dal potenziale “interlocutore”, che legge. Così siamo in presenza di un’indagine psicologica a carattere autobiografico, che scava nei pensieri e nelle intenzioni di un uomo addirittura fragile, con dei traumi infantili mai risolti, pieno di paure e di complessi, senza l’obiettività che troveremmo in una sistematica biografia. Per questo il libro non ha le caratteristiche della narrazione saggistica, ma rientra nel genere del romanzo storico.
La delicata operazione condotta da Lerchenwald mira a restituire Hitler alla sua storia reale, non mitizzata, riducendolo a una dimensione che lo avvicina, piuttosto, all’umana miseria.
Perché non credere che il piccolo Adolf avesse subito il trauma di un padre violento, che lo pestava di botte (una volta fino quasi a fagli sfiorare la morte)? o che amasse la madre al punto da tenere sempre con sé, in tasca, anche da adulto, una sua fotografia? Perché non credere al suo amore per i libri e per alcuni “eroi” della storia: Alessandro Magno, Giulio Cesare, Napoleone? Che volesse fare il pittore o studiare architettura non ha nulla di strano, ma sono certa di suscitare una risata se dico che voleva diventare abate o che sognava di fare il tribuno del popolo: un germe buono, avvelenato dall’ambizione e dal risentimento.
La sua rabbia cominciò a manifestarsi quando conobbe i membri del Partito Tedesco dei Lavoratori, di cui farà parte, e trovò il suo principale fondamento nella cocente sconfitta subita dopo la Grande Guerra, quando le condizioni imposte dal “Trattato di Versailles”, il cosiddetto “Patto della vergogna”, umiliarono la Germania con sanzioni che piegarono l’orgoglio della Nazione. E lui, venuto dal nulla, senza una posizione sociale di rilievo, senza un titolo di studio, solo perché aveva le idee chiare e un’ottima capacità oratoria, era riuscito a imporsi prima sui compagni di partito, poi sulla popolazione e a diventare la guida materiale e spirituale di uno Stato alla deriva, unico artefice della rinascita della Germania. Per arrivare a questo dovette quasi “imporsi” una condotta; la regola era non lasciarsi fuorviare dal sentimento. Da qui la sua inflessibile durezza, la spudoratezza degli ordini, il tono militaresco “recitato”, l’esagerata aggressività, che riteneva indispensabili e utili perché gli risparmiavano la fatica di un’opera di persuasione e semplificava le situazioni.
Come credere, invece, al fatto che Hitler non fosse senza cuore!
Eppure non mise mai piede in un lager né volle mai assistere a un’esecuzione, perché lo spettacolo della sofferenza gli rammentava quella vissuta in trincea durante gli anni della prima guerra mondiale, quando la vista della gioventù mutilata lo nauseava e gli faceva venire le lacrime agli occhi.
È incredibile come un uomo che, nonostante tutto, non si riteneva antisemita e che aveva trovato negli ebrei solo la soluzione più semplice per offrire ai tedeschi un capro espiatorio, avesse impiantato una campagna di odio tanto efferata da cancellare pure il senso di umanità in seno alla sua stessa popolazione.
Ed è questa la reale risposta mancante ai fatti tragici della storia: avrebbe potuto un solo uomo, senza l’appoggio quiescente di una popolazione stregata, manipolata, testimone e complice di una politica criminosa e senza l’apporto di uno staff di gerarchi obbedienti e incondizionatamente asserviti al suo volere, diffondere tanto odio e arrivare a concepire, dopo una ferrea politica antisemita, la “soluzione finale del problema ebraico”?
Capire lo spirito tedesco potrebbe aiutare a capire (senza che ciò comporti una giustificazione) anche la figura di Hitler, definito a torto o a ragione un “desolante caso umano”? Perché è come se le due cose fossero inscindibili: se Hitler non avesse trovato terreno fertile in una popolazione piegata dalla crisi economica e stanca di subire le decisioni di un Governo debole, cosa ne sarebbe stato del suo desiderio di megalomania? quale ruolo avrebbero avuto gli ebrei perfettamente integrati nella società tedesca al punto da vantare posizioni di prestigio ed essere tenuti in grande considerazione?
La lettura del romanzo potrebbe prestarsi a interpretazioni equivoche; io ho provato ad andare al di là delle facili deduzioni, a non essere prevenuta, a non agire spinta dal pregiudizio liquidatorio: non ho scoperto un Hitler che meritasse il perdono, né mai cambierò opinione su ciò che è accaduto sotto la sua dittatura, ho, tuttavia, capito che le responsabilità sono tante e che a fronte della teatralità di un dittatore senza scrupoli c’è un intera popolazione che avrebbe potuto fare molto per evitare un dramma senza precedenti e invece ha taciuto.
Ricordare la Shoah è un atto di grande rispetto verso la memoria di eventi tragici, ma c’è ancora ampio margine per un dibattito costruttivo che, senza rispondere a interrogativi che non avranno mai risposte, può rendere una consapevolezza in più e favorire un maggiore atteggiamento critico, di cui ritengo ci sia sempre bisogno.